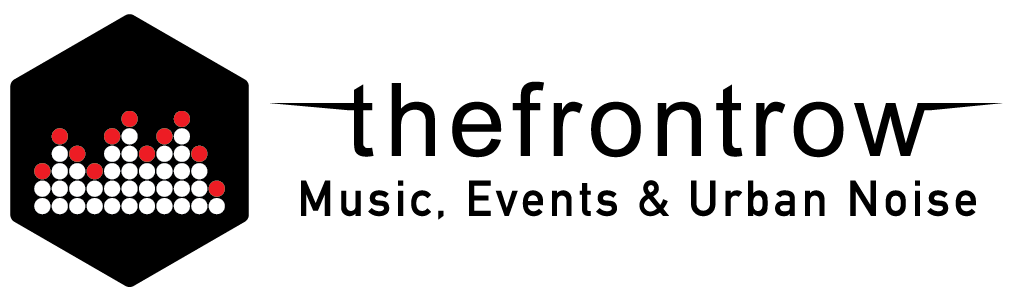Gianmaria Testa se n’è andato, in punta di piedi, senza disturbare. In occasione del suo tour americano, organizzato poco prima del Natale 2014, ebbe un malore. Gli approfondimenti clinici rivelarono che per lui sarebbe iniziata una lotta impari contro un male inoperabile. Non si perse d’animo e iniziò le cure. Un anno e mezzo di lotta, che gli ha permesso solo saltuariamente di poter fare ciò che più amava: la musica. Oggi è arrivata la ferale notizia della sua morte. Sul suo profilo Facebook è stato pubblicato un laconico comunicato:
«Gianmaria se n’è andato senza fare rumore. Restano le sue canzoni, le sue parole. Resta il suo essere stato uomo dritto, padre, figlio, marito, fratello, amico».
Un po’ tutti i notiziari gli hanno reso omaggio e anche noi vogliamo salutarlo, regalandovi questa intervista, realizzata nel suo ultimo tour Vitamia. Con un calice di Arneis in mano Gianmaria si è raccontato ai nostri microfoni. Al nostro fianco c’era la figura discreta di Paola Farinetti, compagna e amministratrice di Produzioni Fuorivia, che ha organizzato questo incontro, poco prima del suo concerto di Bra (Cuneo).
Gianmaria, è stato così difficile diventare “profeta in patria”?
«Io non mi sento profeta di nessuno e men che meno in patria. Certamente nel mondo dell’apparire, se tu rinunci a pigiare sull’acceleratore, ci impieghi molto di più ad emergere. A me non dispiace il fatto di arrivare alle cose per gradi, mettendoci il tempo necessario. In questa epoca abbiamo perso la capacità di avvicinarci alle cose secondo i nostri ritmi. Tutto funziona secondo le regole della pubblicità e non della conoscenza diretta. Così succede che la gente sente parlare talmente tanto di una cosa che alla fine la compra. A me questa cosa disturba un po’. Preferisco che il pubblico abbia il tempo di ascoltare, acquisire, capire e poi comprare. Ecco questa è la mia dimensione, che forse funziona poco commercialmente, ma umanamente è la migliore».
Come mai la tua carriera è partita in Francia?
«Credo sia stato un caso. Scrivo canzoni da quando avevo 10 anni. Ad un certo punto sono stato preso dalla voglia di capire se le cose che facevano potessero piacere anche agli altri. A Recanati c’era un festival dedicato a musica e poesia. E’il 1993 e decisi di mandare una cassetta. Il comitato di garanzia di quel festival era presieduto da Fabrizio De Andrè, Dario Bellezza, Nanda Pivano e tanta altra gente di cui mi fidavo. Alla fine vinsi il premio pari ad un milione di lire. Nel pubblico c’erano anche tanti addetti ai lavori, tra i quali un produttore di Roma, che mi propose di rivedere le mie canzoni, che erano belle, ma non valide commercialmente. Io rifiutai, ma in compenso usai i soldi del premio per registrare in modo professionale due miei pezzi. L’anno dopo partecipai una seconda volta e vinsi ancora, ma già pensavo tra me e me che avrei chiuso con la carriera pubblica. In platea, però c’era una giornalista francese che scriveva per il Manifesto e per il Corriere della Sera. Questa signora si offrì di sottoporre il mio materiale ad una produttrice francese che conosceva. Dopo un paio di mesi mi arrivò una chiamata ed io pensavo fosse una parente di Marsiglia. Impiegai un bel po’ a capire che invece si trattava della produttrice. Passarono ancora due mesi e mi richiamò dicendo che ben tre case discografiche erano interessate a me. E così incominciò la mia carriera»
Fu un inizio in sordina?
«Scelsi la casa discografica più piccola, perché facendo il ferroviere non me la sentii di fare un passo troppo lungo. Uscì Mongolfiera e fu accolto con grande entusiasmo dai transalpini, una vera e propria rivelazione»
Arrivò anche l’esibizione all’Olimpia di Parigi
«Anche quella fu una coincidenza. Dopo un concerto su Radio France, mi contattò il direttore artistico del teatro e mi propose di tenere un concerto, prima che iniziassero i lavori di rifacimento. Accettai al volo, anche se fui molto timoroso della cosa. L’aver funzionato a Parigi mi garantì una grande visibilità in tutti i paesi fracofoni e questo fu il mio acceleratore. Questo nonostante non sapessi bene il francese».
Hai sempre cantato in italiano?
«Salvo rarissime eccezioni si. Ho proposto un brano di Leo Ferret e poi, a mo’ di sfida ho deciso una volta di cantare in piemontese. Ero molto convinto di questa cosa, perché volevo raccontare alla gente delle mie radici».
E in Italia?
«In Italia non ho voluto cedere alle lusinghe del circo mediatico e così rimasi nelle ferrovie fino al 2007».
Parliamo dell’aspetto musicale e dei testi. Tu sei un autodidatta. Quando hai scelto di imparare l’hai fatto per mettere la tua musica al servizio dei testi, o semplicemente le due cose sono cresciute insieme?
«Io sono nato con il canto. Il primo ricordo nitido è un matrimonio. Avevo 5 o 6 anni e sentivo i parenti cantare e per me fu una cosa meravigliosa. Pochi mesi più tardi fui ammesso nella cantoria della chiesa e cantai l’Ave Verum. Pur non capendo nulla di latino, rimasi affascinato da questa esperienza. Poi mio padre mi regalò una chitarra e fu inevitabile legare il suono al canto. Ed è sempre stato così».
Da ragazzo di campagna appassionato di musica cosa ascoltavi?
«In casa avevamo la radio, con cui sentivamo Lascia o Raddoppia. Tra parentesi per me fu una grossa delusione, quando collegai il volto alla voce di Mike Buongiorno. Poi ascoltavamo gli incontri di boxe. Insomma vedevamo le cose alla radio. La musica era quella di quei tempi, Rita Pavone o poco altro. Un giorno un amico più attrezzato di me mi fece ascoltare Il Gorilla, un brano scritto da Georges Brassens e tradotto da Fabrizio De André. A quel punto capii che nel mondo c’era chi scriveva le canzoni per dire delle cose, e non solo per far vedere che aveva una bella voce. Così mi si aprì un mondo nuovo e da lì è stato automatico abbracciare questa filosofia. La canzone è un’arte minore, ma ha un potere di penetrazione eccezionali».
Tra i temi affrontati da Gian Maria Testa c’è anche quello dell’immigrazione. Perché questa scelta?
«Per vergogna. Se tu esci dall’Italia ti accorgi come siamo messi male. Non sto parlando della crisi, ma dell’atteggiamento. Noi siamo probabilmente il popolo che ha avuto il più elevato tasso di emigrazione in tutto il mondo. Ci sono almeno 35 milioni di nostri connazionali sparpagliati ovunque e credo che il nostro paese non possa permettersi di fare demagogia su questo tema. E’ impensabile approvare leggi contro l’immigrazione. Gli italiani partivano per l’ignoto con la certezza di arrivare da qualche parte. Ora noi vogliamo respingere chi parte per l’ignoto, non sapendo nemmeno se la barca che lo trasporta giungerà a destinazione. La disperazione è a livelli così alti che per morire nel tuo paese di origine, tanto vale tentare la sorte e morire in una barca. Io ho scritto questa cosa per me e per i miei figli. Per ricordare chi siamo e da dove veniamo. Non dico che chi arriva non crei problemi, per l’amor del cielo, ma io vorrei ricordare che noi abbiamo esportato Al Capone».
Hai dichiarato che apprezzi molto il mondo dell’ermetismo. Questo vuol dire che anche il tuo modo di scrivere si avvicinerà a questa corrente letteraria?
«Si fanno troppe parole urlate. Le parole si usano a sproposito, per la menzogna, per la demagogia. Non importa il significato, conta solo chi urla più forte. La nostra conquista più grande è stata proprio la possibilità di comunicare e allora sfruttiamo la cosa in modo positivo. L’ermetismo cui facevo cenno non è quello poetico, ma semplicemente quello intellettuale. Parliamo poco, ma facciamolo bene. La grande vittima di questo tempo è la verità: anche le cose certe diventano opinioni da confutare».
In tutta questa carriera straordinaria c’è qualcosa che non rifaresti?
«Umanamente no. Non ho mai tradito le mie idee e accettato i compromessi. La musica per me vuol dire libertà. Forse mi piacerebbe ricantare certi brani cercando di essere più me stesso. E’ capitato a volta di esibirmi in posti che mi hanno condizionato per la loro storia o per chi si era esibito prima di me. Ecco l’emozione e il pensiero di dove mi trovavo mi ha portato ad essere un po’ meno me stesso. Oggi con il senno di poi me ne infischierei. Ma ormai quello che è fatto e fatto e indietro non si può più tornare».
Foto e testo di Vincenzo Nicolello